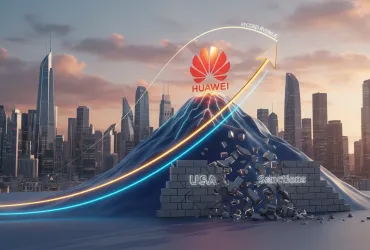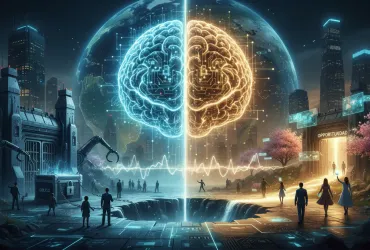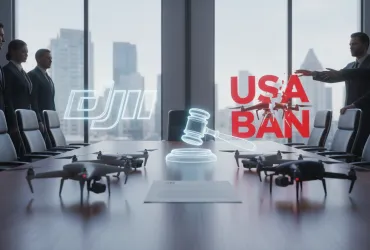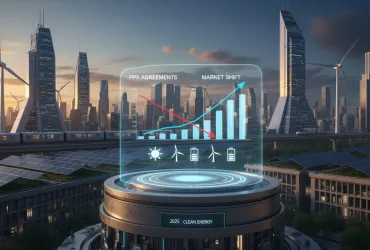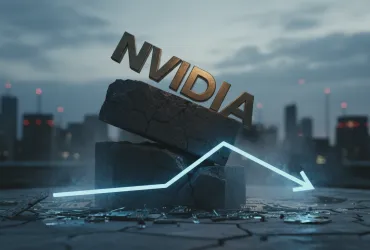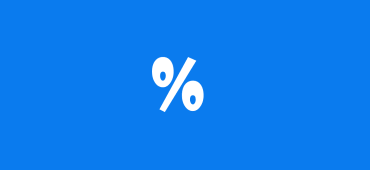Circa 14.000 anni fa, la Terra fu colpita da un evento solare di proporzioni inimmaginabili, una tempesta circa 500 volte più potente di tutte quelle finora registrate. Questa antica tempesta solare ha lasciato una traccia indelebile sulla nostra planetia, segnando simbolicamente la fine dell'ultimo periodo glaciale e l'inizio dell'epoca ologocena. Le scoperte sono frutto del lavoro di una squadra internazionale di scienziati, che ha saputo ricostruire questo evento senza precedenti grazie a una nuova modello clima-chimico specificamente sviluppato per studiare l'attività delle particelle solari del passato.
La ricerca, che ha identificato questo fenomeno intorno al 12.350 a.C., non solo amplia il calendario delle tempeste solari conosciute finora, ma ridefinisce anche le ipotetiche soglie di intensità che possono essere raggiunte da tali eventi. Questi risultati sollevano domande cruciali sul possibile ripetersi di simili fenomenologie e sull'impatto che potrebbero avere sull'attuale infrastruttura elettrica terrestre, decisamente più vulnerabile in una società tecnologicamente dipendente come la nostra.
Dai precedenti studi basati sugli anelli degli alberi e le analisi delle carote di ghiaccio, era noto che un forte evento solare si fosse verificato in quegli anni, ma la sua intensità restava ancora avvolta nel mistero. Grazie ad una metodologia avanzata, sviluppata dall'Università di Oulu in Finlandia sotto la guida della dottoressa Ksenia Golubenkova e del professor Ilya Usoskin, è stato possibile determinare che questa tempesta fosse del 18% più intensa del successivo massimo solare significativo registrato, ovvero quello avvenuto nel 775 d.C..
La modellazione effettuata attraverso il sistema SOCOL:14C-Ex ha permesso di risalire con precisione alla tempesta solare datata 12.350 a.C., utilizzando come confronto l'evento conosciuto del 775 d.C. Questo strumento avanzato è stato fondamentale nell'individuare una tempesta dell'epoca glaciale, avvalorata dai risultati ottenuti dagli anelli degli alberi delle Alpi francesi che contenevano tracce di elevate concentrazioni di radiocarbonio.
Questi dati inediti hanno reso possibile l'identificazione del 12.350 a.C. come il primo esempio documentato di evento estremo di particelle solari, segnando una pietra miliare nello studio delle relazioni climatiche e solari storiche. La dottoressa Golubenkova ha sottolineato l'importanza di tale modello, che sta eliminando importanti ostacoli nella ricerca sulle condizioni climatiche durante i periodi glaciali.
La scoperta pone in evidenza anche i cosiddetti insieme di eventi "Miyake", caratterizzati da improvvisi picchi di radiocarbonio che possono fungere da riferimenti temporali geologici. L'identificazione di queste tracce ha già consentito la datazione di antichi insediamenti vichinghi a Terranova, così come alcune comunità neolitiche in Grecia. Il professor Usoskin evidenzia l'utilità di tali metodi di datazione, che offrono punti di riferimento unici per la calibrazione dei metodi di datazione basati sul radiocarbonio, essenziali per la ricostruzione dettagliata dell'ambiente terrestre e il suo legame con il comportamento solare.
La comprensione di queste tormentose tempeste del passato ha aperto nuovi orizzonti sullo studio dell'attività del Sole, lasciando intravedere le possibili conseguenze di eventi simili che potrebbero verificarsi oggi. Le implicazioni per le nostre attuali infrastrutture tecnologiche, inclusi i satelliti e i sistemi di comunicazione globale, richiedono maggiori attenzioni e preparazioni, considerando che il loro impatto potrebbe essere devastante se sottostimato.